Mauro Corona racconta il suo Vajont
ertoecasso.it il portale di Erto e Casso!
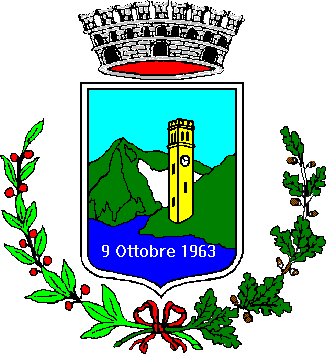
Mauro Corona, scrittore, scultore e alpinista, personaggio autorevole e sensibile ai temi del rapporto fra l’uomo e la natura, ci racconta, in un’intervista a tratti commovente, come ha vissuto la giornata del 9 ottobre 1963 e l’impatto che ha avuto sulla sua vita l’immane tragedia.
In questa pagina presentiamo la versione trascritta, per chi preferisce leggerla e, di seguito, il video integrale dell’intervista.
Mauro, ci puoi raccontare come hai vissuto la giornata del 9 ottobre 1963?
Il 9 ottobre del ’63 avevo tredici anni. Il mattino di quel giorno ero a Longarone. Le scuole medie al tempo erano già obbligatorie.
Lo vivevo come un trauma. Dopo le vacanze estive abbandonavo la malga (in cui facevo la stagione come bracciante e pastore) per andare a scuola a Longarone. L’impatto era micidiale perché eravamo bambini selvatici, liberi e facevamo veramente fatica a stare assieme ad altri ragazzi sconosciuti, ad abituarci ai compiti da fare e ai libri da studiare, con una disciplina da seguire assai diversa da quella della malga.
Fino alle 14:00 di quel giorno quindi, ero a Longarone. Successivamente tornai a Erto. La vita andò avanti regolare fino alla sera.
Ricordo benissimo mia nonna che diceva: “preghiamo perché viene giù il Tóc”. I segnali e le avvisaglie purtroppo c’erano: terremoti, scossoni e la spaccatura del monte che si apriva un metro e mezzo al giorno.
Io e i miei fratelli eravamo da soli coi nonni perché mio padre era a caccia, in giro per i boschi, da una settimana.
Ricordo bene il nonno: un omone alto un metro e novantasei. Oltre a loro, viveva con noi anche una zia sordomuta.
La notte si andò a dormire. A un certo punto sentimmo un fortissimo terremoto. Era il terremoto del Vajont. Un rumore che solo i sopravvissuti possono ricordare e che nessuno mai potrà imitare. Il rumore di quella notte fu qualcosa di indescrivibile.
Pensiamo a un camion di ghiaia che si scarica. Già così il rumore è infernale. Immaginiamoci quel che potrebbe accadere con una frana del genere. Era come se un miliardo di aerei ci stessero passando sopra la testa nello stesso istante.
Mancò la luce. Gli ertani si trovarono in strada. “È venuto giù il Tóc”.
Non sapevamo di essere tutti miracolosamente scampati alla morte grazie al gobbone del monte Borgà che deviò l’acqua risparmiando il centro. Purtroppo l’onda si abbatté sulle frazioni popolate di San Martino, Piénda, Prada, Lirón, Marzana, Savéda, Il Cristo, Fraséing e Le Spesse facendo una strage.
Ricordo una vecchietta, che abitava a un metro dalla nostra abitazione, che aveva un figlio guardiano sulla diga. Di lui non è stata trovata neppure una minima traccia. A volte mi chiedo cosa possa aver visto quell’uomo. Era un bell’uomo. Si chiamava Felice, lo ricordo benissimo, il Venerdì Santo faceva la Parte del Cristo.
Gli ertani dicevano: “bisogna andare in alto”. Riparammo in una casa in cima a un colle, un’abitazione della famiglia dei “Davìde” (Giulio Davide) e nel frattempo un uomo che si chiamava Rico si recò a San Martino, un’altra delle frazioni colpite, per controllare la situazione lì, dal momento che non si vedevano più le luci del borgo.
San Martino non c’era più.
Altri invece raggiunsero Casso per osservare il fondovalle e cercare di capire cosa era successo a Longarone, ma non videro le luci di Longarone.
Da Casso provenivano urla strazianti.
E allora si capì che era successo qualcosa di grave.
Ad un certo punto, come tutti gli ertani, sei stato portato via dal tuo ambiente naturale, hai cambiato località, sei finito in collegio. Come è andata?
All’indomani del disastro del Vajont cominciarono ad arrivare gli elicotteri. Il monte Tóc non c’era più e a quel punto ci si rese conto ancora di più della portata del disastro.
Si vedeva tutta un’ossatura bianca e giallastra al posto della montagna e della valle, il lago rimaneva melma, e noi fratelli fummo portati con gli elicotteri a Cimolais e sistemati in una colonia alpina che alloggiava studenti in estate. Rimanemmo lì tre o quattro giorni.
Nel frattempo rientrò mio padre dalle sue battute di caccia, che duravano anche settimane, e ci raggiunse con un’auto. Ci disse: “montate su”. Salimmo io e il mio secondo fratello. Il più giovane rimase.
Quel giorno papà ci portò al collegio Don Bosco di Pordenone.
Per me, abituato all’aria aperta, a camminare, correre, scalare e a fare il pastore, cambiare esistenza, seguire una disciplina ferrea al cui confronto la naja fu una bazzecola, (ho fatto il militare a vent’anni), lontano dalla mia casa e dalla mia terra, fu un altro trauma terrificante.
Però il collegio di Pordenone ebbe anche il merito di “sgrezzarci”. I sacerdoti ci fecero capire, nel mio caso soprattutto, cosa avrebbe potuto interessarci nella vita, cosa avremmo potuto fare. A me piacevano le materie artistiche, leggevo molto. Allora i preti mi davano pile di libri, “a metro”, da leggere e studiare.
“Quest’anno leggi questi” mi dicevano.
Non sarò mai grato abbastanza ai preti del Don Bosco per avermi fatto leggere, a quattordici anni, il "Don Chisciotte", un libro che non dovrebbe mancare mai in ogni famiglia, tutti lo dovrebbero leggere.
Il Cavaliere della Mancia, che non è mai sconfitto perché è sempre sconfitto. Si rialza e dice “non è niente” e si scrolla la polvere di dosso esultando: “ripartiamo”.
Disprezzato da Dulcinea, egli la ama lo stesso perché pensa “in fondo mi vuole bene”. Ecco questa è la lezione del libro.
Lì (al collegio) ottenni la licenza di terza media. Gli insegnanti mi hanno fatto capire che potevo anche scrivere. Mi piaceva scrivere i temi in classe (in compenso in matematica ero uno zero) e Don Teodoro Matiel, che aveva tre lauree, professore di Italiano, capiva la mia passione. Mai avrei immaginato che in futuro avrei scritto dei libri.
Durante la pausa estiva si tornava nella nostra casa a Cimolais, però la mia testa pensava a Erto, il mio paese e, appena avevo l’occasione, fuggivo per tornare a camminare fra le sue vie abbandonate.
Crescendo, secondo te, quali profonde ferite lascia dentro a una persona una tragedia come quella del Vajont?
Il dramma del Vajont ha lasciato una memoria di nostalgie, di una patria perduta. Ha cancellato usi, costumi, tradizioni, la cultura del tempo, l'artigianato, il taglio del fieno, la fienagione, i boscaioli. Tutto scomparso. La comunità fu smembrata e disseminata per la pianura come chicchi di granturco. Si ricostruì una borgata nuova dalle parti di Maniago (Vajont), un’altra dalle parti di Belluno (Nuova Erto) e la gente venne portata in questi luoghi.
Alcuni scelsero di rimanere.
Le radici sono elastiche, ci si allontana ma appena si molla la presa esse ti riportano ai luoghi dell’infanzia, che è il tuo paese, il luogo dove sei nato.
Per me il Vajont è anche il dopo, il non essere più uniti.
Hanno ricostruito qui una cittadina di cemento dove le cucine non esistono più come le ricordavo. Ci sono questi salotti immensi, è stato davvero difficile adattarsi a una nuova casa, nel vero senso della parola. Le case ora non sono di pietra.
In cucina ci si radunava a conversare con le storie della sera, con le decisioni, si stabilivano vita, morte e miracoli e si concludevano affari e c’era sempre un pentolone di fagioli fumante che bolliva sul forno.
Ora so che non si vive di nostalgia ma uno dei drammi più gravi del Vajont, oltre ai duemila morti che non si devono mai dimenticare e ai quali si devono eterno rispetto e memoria è stato anche il dopo. Un’intera civiltà è stata annientata in un secondo. Tutte le civiltà come i Maya, gli Inca, gli Aztechi, gli Egizi sono state distrutte lungo i secoli; col Vajont ci hanno messo due minuti. Non siamo più esistiti. Erto è un paese senza più i suoi custodi di sapienze antiche, o di “minute sapienze”. Come diceva Borges: “Amo le minute sapienze che in ogni morte scompaiono”.
Questi saperi erano eccezionali e grandiosi ma purtroppo stanno scomparendo.
Chi è nato appena dopo il Vajont ora ha più di cinquant’anni, la memoria assurdamente ha già iniziato a sbiadire da allora. Essi non hanno vissuto il Vajont, non ne portano le cicatrici.
Tutto si sta acquietando nell’oblio e del Vajont rimarrà qualche notizia sui libri di storia ma in chi c’era, finché vive, rimarrà il dolore.
Avrei potuto andare via dal paese, avrei avuto mille occasioni per farlo ma sono rimasto qui. Qualcuno potrebbe chiedersi perché. A costoro rispondo con una citazione di Hofmannsthal (ritiratosi a vivere in un paesino della Carinzia):
Amo immensamente questa terra e più passano gli anni più essa mi sembra ricca. Quando sarò vecchio, dai suoi boschi e dai suoi torrenti mi verranno incontro i ricordi dell’infanzia e il cerchio si chiuderà.
 Coriokì Studio
Coriokì Studio
