L'operaio al cantiere della diga.
ertoecasso.it il portale di Erto e Casso!
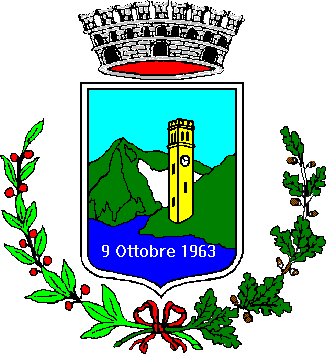
Giuliano de Lorenzi, classe 1934.
Ha lavorato nel cantiere di costruzione della diga. I suoi genitori sono morti nel disastro del Vajont.
Abita a Casso, un crocevia di case in pietra e stradine acciottolate, abbarbicato sopra le pareti strapiombanti della falesia del Vajont.
Giuliano è uno dei suoi 26 abitanti.
In un minuscolo spazio ricavato da un vecchio fienile, Giuliano conserva gli equipaggiamenti dei mestieri cui si dedica quotidianamente. Ci sono zappe, rastrelli, martelli, cassette degli attrezzi, pastrani e toni appesi al muro, un mini-tosa erba a motore, decespugliatore e altri aggeggi.
Su una delle pareti dello sgabuzzino c’è una foto in bianco e nero. Sono ritratti i suoi parenti, le persone a lui più care.
“Tutti morti nel disastro del Vajont” dice guardando a terra, prima di incamminarsi verso il bar e iniziare l’intervista.
Accetta cordialmente di parlare ma lo fa con una sorta di emozione distaccata, come se avesse vissuto un sogno.

Ciao Giuliano. Grazie per aver accettato questa intervista. Vuoi presentarti?
Mi chiamo Giuliano, sono nato e cresciuto a Casso. Ho sempre lavorato fin da ragazzo come carpentiere, muratore, operaio.
Ho lavorato sul passo dello Stelvio, poi nel ’54 ero a Punta Sabbioni. Al termine dell’impiego nel Vajont mi sono sposato e dal ’62 al ‘69 sono stato assunto a Torino, operaio FIAT. Infine ho deciso di tornare e stabilirmi qui. Per ironia della sorte impiegato presso l’ENEL.
Non saprei cos’altro dire di me.
Come sei finito al cantiere per la costruzione della diga del Vajont?
Sapevo che l’impresa Torno di Torino cercava operai per costruire la “diga a doppio arco più alta del mondo” e decisi di arruolarmi.
Nel settembre del 1956 entrai a far parte del corpo lavoratori della SADE che iniziò la costruzione del cantiere del Vajont, che poteva essere considerato una cittadina tanto era grande e complesso. Solo gli operatori non specializzati erano più di quattrocento. Venivano dalle valli vicine ma anche da fuori, dall’Abruzzo. Finimmo per diventare una grande famiglia. Ci conoscevamo tutti, nome e cognome.
Mi occupavo delle armature per le gettate di calcestruzzo. Come gli altri, svolgevo anche tante altre mansioni, a seconda delle necessità. C’era sempre un mucchio di roba da fare.
La costruzione dello sbarramento rappresentava la parte finale dell’intero progetto. Prima andava predisposto tutto il resto. Gli scavi di fondo per avviare le imposte per le gigantesche volte, l’area mensa e i dormitori, le stazioni per la teleferica con le torri mobili, il posizionamento delle enormi gru, senza dimenticare le vie di comunicazione interne e la nuova strada per mettersi in comunicazione con Longarone. Venne perfino costruito un ponte nuovo sulla forra del Colombér, il ponte Mantelli, per attraversare la valle con gli automezzi e raggiungere l'area di costruzione.
Era formato da due semi-archi che poggiavano su due enormi cardini. Il giorno in cui le due metà vennero lentamente calate con funi e tiranti fino a congiungersi c’era un mare di gente: venivano da Erto, Casso, Longarone, Belluno, dal Cadore.
Insomma, costruire il cantiere sul Vajont fu come costruire una piccola cittadina e tutti i servizi e le infrastrutture di cui aveva bisogno, comprese le strade.
Con la diga ci abbiamo messo meno.
Riuscivamo a costruire una media di 60 centimetri al giorno.
Il tutto durò circa quattro anni: nel ’56 iniziavano i lavori degli scavi di fondo e a novembre del ’60 la chiusa era praticamente ultimata.
Cosa ti è rimasto impresso di quegli anni?
In cantiere operavano strutture, attrezzature e strumentazioni all’avanguardia.
Seguivamo le istruzioni degli ingegneri, dei periti edili, dei progettisti, dei topografi e dei geologi. Avevamo la sensazione di partecipare a qualcosa che sarebbe rimasto nella storia. Al tempo la diga era considerata una delle opere più grandiose mai ideate, progettate e realizzate. L’opera terminata è un mostro di trecentosessanta mila metri cubi di calcestruzzo.
Tante cose mi sono rimaste impresse.
Per esempio la teleferica per rifornire il cantiere del Vajont. Collegava funi portanti tese fra Longarone ed Erto. I suoi cavi si sviluppavano oltre 1400 metri. Partivano da quota 442 metri e salivano fino a quota 770. I carrelli che li percorrevano viaggiavano a una velocità di oltre tre metri al secondo e caricavano oltre 1200 chilogrammi ognuno. A metà del percorso le funi della teleferica passavano attraverso una stazione intermedia che permetteva ai cavi di curvare e raggiungere la fermata dell’area Moliesa (la stessa su cui oggi si trova il centro informazioni). Essa era posizionata sul costone nord della forra del Colombér, ed era una struttura di cemento armato e acciaio che formava un enorme arco. Per armarla utilizzammo oltre 150 metri di tubi innocenti.
Oggi si possono ancora vedere i piloni che sostenevano il gigantesco arco di ferro su cui correva il cavo. Si trovano nel fitto bosco al termine della Ferrata della Memoria, sopra il torrente Vajont.
Le funi portanti venivano costantemente tenute in tensione. A seconda del carico presente su di esse, venivano caricati enormi contrappesi situati nella stazione inferiore, a Longarone. Ricordo che si trattava di quattro contrappesi in tutto. Erano degli enormi blocchi di cemento, due del peso di 300 quintali, altri due di 700 quintali. Se ricordo bene. Quando la teleferica era carica i contrappesi salivano, quando era scarica scendevano, in modo da tenere il cavo sempre trazionato.
Uno degli operai dell’Abruzzo, non ricordo il nome, si faceva mandare su le lettere della fidanzata assieme ai materiali inerti trasportati con la teleferica.
Per gestire il calcestruzzo invece venivano utilizzate due gru-teleferica denominate Blondin, dotate di torri mobili posizionate lungo il fianco nord della valle e montate su una rotaia che permetteva loro un movimento laterale di 100 metri. Io le definisco torri ma in verità erano talmente grandi da sembrare delle case su rotaie. Sull’altra sponda della valle era posto un pilone fisso. Le funi che collegavano questi tre elementi trasportavano benne capaci di servire 40 metri cubi di cemento ogni ora. Muovendo le torri era possibile direzionare il cavo e adattare il corso delle benne. In questo modo si potevano seguire accuratamente la posizione orizzontale e verticale dello stato dei lavori. La forma della diga infatti, mentre saliva, cambiava, essendo appunto una struttura a doppio arco.
I Blondin erano manovrati da ertani. Neanche guardavano dove il cavo si tendeva. Conoscevano posizione e direzione semplicemente regolando le strumentazioni dei macchinari, tanto erano sofisticate.
Le benne inoltre erano dotate di un meccanismo automatico azionato manualmente che ci permetteva di calarle fino al punto in cui si stava lavorando, facendo così arrivare il cemento ad ogni quota.
Sul versante opposto invece si trovava una gru con un braccio di oltre 60 metri capace di portare fino a sei tonnellate.
Per spostarci più agevolmente durante la costruzione, utilizzavamo anche un ascensore a quattro fermate capace di trasportare dieci persone al colpo. Scorreva all’interno della roccia, in un foro appositamente scavato. Le fermate erano quattro: scarico di fondo, scarico di mezzo fondo, centrale e scarico di superficie.
Raccontaci com’era lavorare lì, che atmosfera si respirava.
L’attività procedeva non stop, 24 ore su 24, giorno e notte, alternando tre turni di lavoro divisi fra tutte le squadre di operai.
Lavorare alla diga del Vajont era faticoso.
I fori nelle putrelle venivano effettuati manualmente, tanto per fare un esempio.
Faticoso e pericoloso.
Ricordo che gli operai parlavano poco. Oltre al rumore degli attrezzi, delle gettate di cemento, delle ruspe, sulla piattaforma che si andava via via innalzando si sentivano poche voci. Se si diceva qualcosa doveva essere per comunicare lo stretto necessario. O per avvisare che qualcosa non andava.
Eravamo tutti concentrati. Sapevamo che una distrazione poteva costare cara. Erano già morte delle persone precipitate nel vuoto durante la perforazione dei pozzi necessari al funzionamento dell’intero impianto.
Tuttavia gli incidenti non mancavano. Io per primo assieme al mio compare di lavoro, un ragazzo di Erto, Giulio Corona “de Mamanin”, ne sono stato testimone diretto.
Durante lo scavo delle gallerie di mezzofondo nel ‘58 stavamo immettendo cemento per ostruire un tunnel. Il tubo che pompava il cemento compiva un cambio di direzione piuttosto repentino sottoponendo la tubazione ad un angolo che risultava assai pericoloso. Era come piegato, per intenderci, e rappresentava un punto debole. Le nostre segnalazioni al riguardo vennero prese in considerazione, certo, ma quel lavoro doveva essere fatto velocemente e subito. La tubazione perciò sarebbe stata cambiata il giorno successivo. Un boato e il cemento iniziò a schizzare a una velocità impressionante: il tubo si era spaccato. Quindici di noi vennero schiacciati contro la roccia dal getto, otto di loro finirono in ospedale. I più fortunati furono quelli come me che trovarono riparo contro la parete di uno scavo di scorrimento per l’acqua. Il mio compare Giulio fu gravemente ferito. Passò più di tre mesi all’ospedale di Belluno prima di riprendersi. È stato anche in coma.
Purtroppo per Giulio non era ancora finita, non sapeva che l’anno dopo sarebbe stato ferito in maniera ancora più grave.
Accadde che lavoravamo nel pozzo centrale, 30 metri sotto la camera di espansione. Là sopra, in quel momento, si stavano effettuando delle perforazioni per allargare l’accesso che, così com’era, impediva il passaggio di particolari pannelli di costruzione.
Udii un fischio e poi come un latrato. Girandomi vidi l’amico colpito alla spalla da un grosso sasso. Io ero stato miracolosamente risparmiato. Il macigno mi aveva sfiorato. Veniva dalla camera di espansione, un distacco provocato dalle trivelle lassù.
Quel giorno Giulio non fu fortunato quanto me. Passò quattro mesi in coma. Al suo risveglio non era più lo stesso. Raccolsi il sasso appena dopo l’incidente e quando Giulio fece ritorno a casa glielo portai. Pesava circa un chilo e mezzo. Il sasso si trova ancora lì, nel centro storico di Erto.
Cosa ti rimane di quell'esperienza?
Ho costruito la morte dei miei genitori e non li ho salvati.
Ricordo che i miei genitori la sera prima della notte del disastro del Vajont, erano nella casa sul lago, fra quelle risparmiate dagli espropri perché edificate sopra il livello di massimo invaso del lago.
Io invece mi trovavo a Torino perché lavoravo alla FIAT. Mia moglie abitava a Casso, in una casa che è stata risparmiata dall’ondata del disastro del Vajont. Mia moglie e mia suocera mi raccontarono che andarono dai miei genitori chiedendogli di andare su da loro, perché più sicuro. In paese, a Erto e in tutte le frazioni, la gente sapeva ormai della frana in movimento e che attorno al lago era pericoloso.
I miei genitori risposero che “no, non sarebbero saliti”. Dissero che la loro casa era quella lì e che non se ne sarebbero mai andati. Era gente orgogliosa, forte di carattere e coraggiosa.
Nessuno immaginava la portata del disastro del Vajont. Nessuno. D’altra parte, come avrebbero potuto?
Dopo quella notte non li ho più rivisti.
A questo punto Giuliano vuota il bicchiere di rosso.
Si mette a parlare con la proprietaria del bar di tutt’altro, come a voler dimenticare in fretta.
 Coriokì Studio
Coriokì Studio
